Di estrazione classica Weber ha sapientemente fuso, sin dal suo esordio come leader con The Colours of Chloë (1974), elementi di questa “scuola” (prevalentemente moderna e contemporanea) sia compositivi sia in termini di strumenti col Jazz e il Jazz-Rock.
E proprio la registrazione giusto mezzo secolo fa (dicembre 1973) di The Colours of Chloë segna subito la carriera di Weber, giacché anche col senno del poi è tra le sue opere più significative, dunque per cominciare a conoscerlo nulla di meglio.
Musica che coniuga mood contrastanti, sovente li giustappone, sempre raffinato; spesso pacato e minimale a volte incalzante, mediamente è denso, con trame di timbri e note di spessore, ossia che hanno una sapienzale profondità armonico-melodica.
Oltre al leader (basso, violoncello e ocarina) ci sono Rainer Bruninghaus (pianoforte, piano elettrico e sinth) Pietro Giger (batteria e percussioni) Ralf-R. Hübner (batteria sul brano omonimo) e Ack van Rooyen (flicorno).
Inoltre c’è una sezione di violoncelli dell'Orchestra Sinfonica Südfunk di Stoccarda; e ai cori lo stesso Weber e Gisela Schäuble.
More Colours:
dopo oltre due minuti di introduzione con una parte di archi alquanto statica, si sovrappone il contrabbasso, per poi a fasi alterne rimanere da solo; nuovamente archi come sfondo, tutti incalzati da un dinamico pianoforte e nel frattempo la trama armonica s’infittisce e destabilizza il centro di gravità melodica con notevoli tensioni mutuate dalla classica del ‘900. Intanto il pianoforte assurge a figura (col contrabbasso che esce di scena), e conduce al termine questo affascinante brano per pianoforte, orchestra e contrabbasso.
The Colours Of Chloë:
entra in scena la batteria con Hübner, con scrosci di piatti su veloci ostinati del piano elettrico (Terry Ryley docet) e una lirica parte con l’arco di Weber.
Segue un leggero ritmo (6/4), e in questa sezione entra l’ocarina a rinforzo lirico dell’ostinato armonico: non può non venire in mente quanto poi caratterizzerà questo suono il Pat Metheny Group (il sinth di Lyle Mays).
Il brano si sviluppa in modo articolato (peraltro è quello più lungo dei tre, quasi 8 minuti), ci sono varie sezioni dove il pianoforte improvvisa su uno scenario jazzistico, ma non convenzionalmente swing (né walkin’ né ritmo batteria sul piatto), con parti giustapposte di Weber che fraseggia in modo cantabile; termina un po’ stranamente, in modo quasi frettoloso, abborracciato, riprendendo la sezione iniziale con l’ocarina.
An Evening With Vincent Van Ritz:
intro di archi che si muovono ancorati a una nota di contrabbasso, poi flebili voci melodiche, vocalizzando, l’armonia si fa sempre più complessa; così per oltre due minuti; pausa, soluzione di continuità per tutt’altro scenario. Batteria, piano elettrico e contrabbasso (molto operoso) per improvvisazione di flicorno, coordinate di morbida jazz-fusion. Termina riprendendo brevemente la prima parte.
No Motion Picture:
è una complicata suite che si apre con un incalzante e asimmetrico (15/8) riff di basso elettrico, rapide note di brevissimi ostinati di piani elettrici si sovrappongono generando un complesso reticolo metrico, aggiungendosi pure dei sinth con parti più articolate. Improvvisamente si innesta una misura di accordi, per poi riprendere il riff di basso; si ripete fino all’innesto che a sua volta si collega (1’31”) una sezione in 7/8 ancor più incalzante. Ancora ripresa del riff iniziale, ma d’improvviso a 2’19” si cambia completamente (peraltro col ponte più breve, elidendo 5/8), sezione lenta, accordale (4/4) con piano elettrico, basso e voci che cantano alcune note dell’armonia (qualche scrocio di piatti).
Pausa, lunga sezione col solo contrabbasso. Pausa, altro riff di basso elettrico, diverso e più difficile del primo (sempre in 15/8), ma le parti dei piani elettrici sono le stesse dell’apertura, tuttavia s’innesta un sinth con parte differente; poi il susseguirsi strutturale è simile, ma non uguale.
7’16”, pausa, nuova sezione con due delicate parti di pianoforte, che s’integrano perfettamente. Progressivamente l’atmosfera si surriscalda, fino a un climax, per poi planare intorno al dodicesimo minuto; solita cesura di pausa e si riprende come l’apertura col riff di basso elettrico (ma coi pianoforti al posto di quelli elettrici), si prosegue (con qualche variazione) fino a un accordo tenuto per tantissimo tempo, s’innestano batteria e percussioni, che poi rimangono da soli e susseguentemente si genera una parte (15/8) dove si sovrappongono i piani elettrici.
Pausa, si ritorna al riff di apertura con la già nota successione di parti, ma qui quella più pacata con voci diviene parecchio più lunga fino quasi al termine del brano, in cui trova ancora posto qualche variazione e guizzo, riemergendo ancora il riff portante dove per la conclusione pure qualche nota di flicorno.
È un disco molto significativo anche per l’estetica della stessa ECM, poiché molto variegato, con le diverse aree che saranno esplorate anche singolarmente da altri musicisti della scuderia (e dallo stesso Weber), pertanto ebbe una notevole influenza pure sulla poetica di molti musicisti.
Ciononostante risente di piccole pecche d’ingenuità nelle forme strutturali, come alcune frettolose riprese delle sezioni, e quelle troppo insistite e stucchevoli nella suite (peraltro un po’ derivativa dei Soft Machine), che appesantiscono il discorso musicale.
Insomma, The Colours of Chloë è un disco importante che fa riflettere pure sul fatto che quando compositori si esprimono in maniera così tanto eterogenea (pur rinunciando al Blues e ai suoi derivati) già alla loro prima opera, spingendosi così in avanti e in alto, cosa ci si può attendere dopo? Ebbene Eberhard Weber ha sempre mantenuto un buon livello di rinnovamento e un alto livello qualitativo anche nei lavori successivi, per molto tempo ancora.
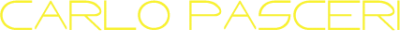



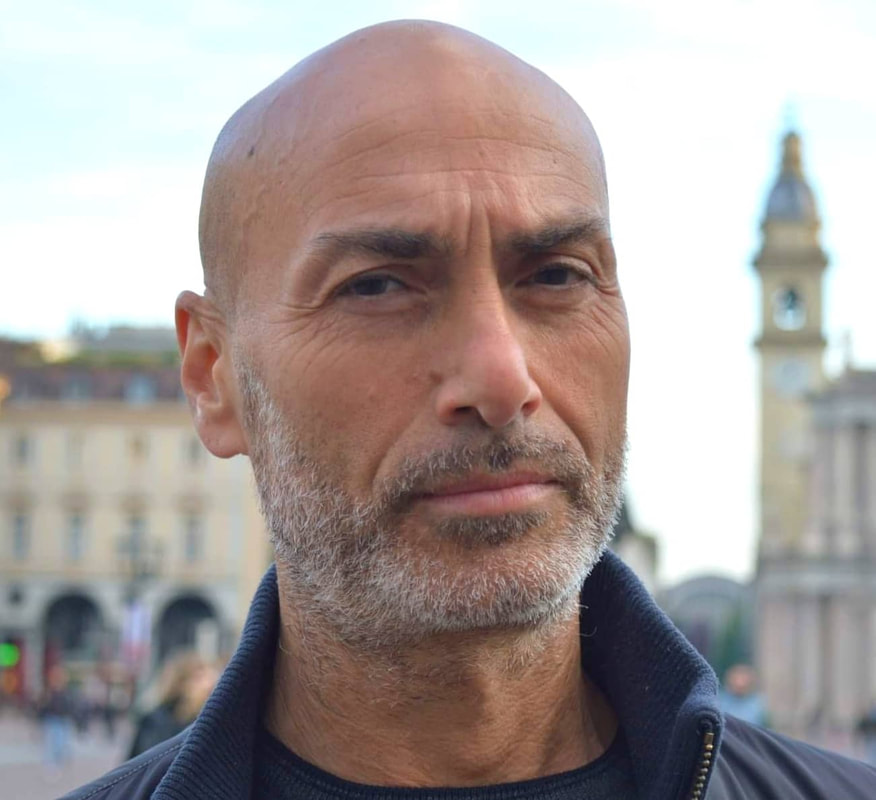


 Feed RSS
Feed RSS
