| Ad agosto sul blog del prof. Odifreddi (noto matematico e divulgatore scientifico) ospite su Repubblica, si è aperta una discussione sul fatto che “nell’arte e nella musica ci sono, e ci sono sempre state, correnti razionaliste che parlano lo stesso linguaggio della matematica. E capire e apprezzare i loro prodotti richiede lo stesso grado di istruzione, e lo stesso livello di addestramento, che servono per capire e apprezzare i teoremi e le dimostrazioni. E’ ovvio che certa arte e certa musica, allo stesso modo della matematica, richiedono uno sforzo superiore di quello sufficiente per guardare una pubblicità, orecchiare una canzonetta o leggere un romanzetto. Anche scalare l’Himalaya o le Alpi è più impervio che andare a passeggio, ma solo così si possono conquistare le vette, delle montagne o della cultura.” Naturalmente ci sono stati numerosissimi interventi di diverso segno, ancorché di diversa profondità analitica. Molti sono d’accordo con il professore, altri no; poi la discussione prende una deriva sull'arte, su cosa è e non è l’arte, quindi sulle definizioni… Può essere utile ricordare che la musica è intimamente il prodotto di “calcoli matematici”, ossia prima ancora di esser composta ed eseguita, l’essenza musicale (suoni, note e ritmi), è matematica. Come è assolutamente frutto matematico il sistema musicale temperato dodecafonico introdotto e usato in occidente alla fine del ‘600. | Consapevoli o meno, quando ascoltiamo musica il nostro cervello effettua dei calcoli... |
Questo è nell’arte una SINGOLARITA': in pittura non tutti sono d’accordo su un quadro astratto o un dipinto che non corrisponda a canoni di realtà oggettiva, prospettica e geometrica, come per la scultura. Addirittura in letteratura pure qualche prosa scritta molto male, non fa a tutti necessariamente inorridire e rifiutare lo scritto con dolore quasi fisico.
In musica sì, inorridiamo e stiamo male, e ciò accade perché il nostro cervello sa cosa basilarmente è giusto e cosa è sbagliato: come per un’operazione aritmetica.
Quando ascoltiamo pure distrattamente della musica il cervello “numera”, anche se noi siamo del tutto inconsapevoli di ciò.
Infatti, quando ascoltiamo delle musiche banali (o comunque estrapoliamo delle cose semplici da qualche musica), è come se al cervello arrivasse 2+2=4; 3+3=6; 4+4=8: musiche più complicate hanno insite “numerazioni” più complicate, che obbligano pertanto il cervello a maggior lavoro e quindi noi di porre maggior concentrazione.
La maggior parte delle persone non apprezza delle musiche complicate, che sono sia intimamente sia implicitamente il prodotto di “calcoli matematici”; queste musiche complicate sono spesso pure frutti di consapevoli e volontarie combinazioni matematiche che il compositore realizza.
Le musiche MENO (quantitativamente) apprezzate sono quelle con i “calcoli” più complicati, ma anche quelle musiche che hanno TANTI “calcoli” elementari e poche ripetizioni: è imbarazzante che nella musica moderna più apprezzata c’è un’esasperata RIPETIZIONE dei pochi calcoli elementari presenti.
Invece quando decretiamo di ascoltare della musica “SBAGLIATA” (seppur semplice) è perché al cervello arriva 2+2=3!
Certa arte e certa musica, come dice il prof. Odifreddi, hanno bisogno di uno sforzo superiore (per esser comprese e apprezzate) pertanto hanno bisogno di istruzioni superiori.
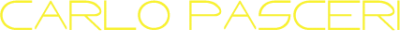

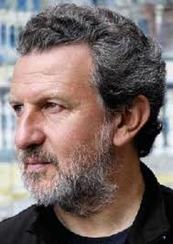
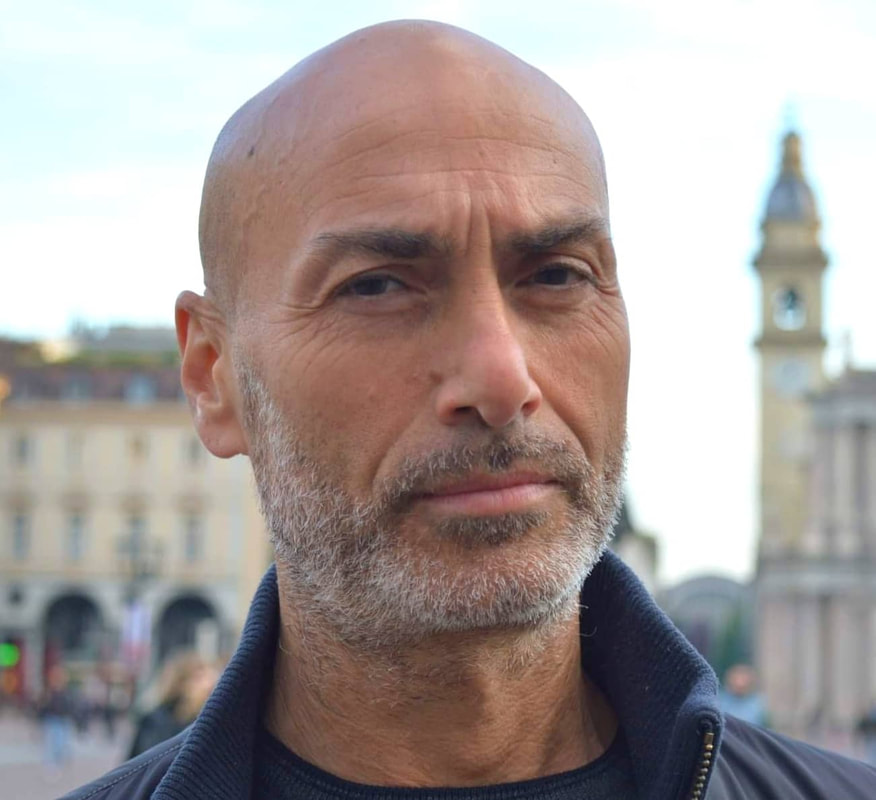
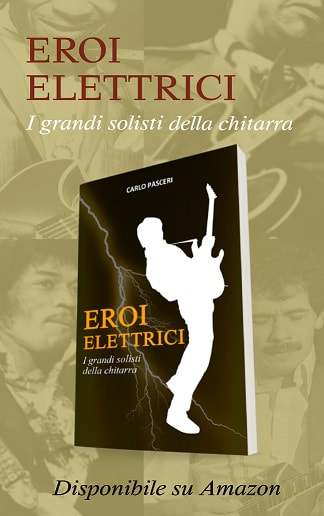

 Feed RSS
Feed RSS
