L’inconscio ma potentissimo fascino delle sequenze ripetitive è che noi immersi in quelle eventualità, ma perfettamente rilassati perché informati, finalmente siamo padroni del tempo.
D‘altra parte la ripetizione è un fenomeno artistico molto “musicale”, e di solito la reiterazione musicale non assume la caratteristica di uguaglianza, ma una riproposizione con minime varianti, facendo così percepire nel continuum lineare quella quasi-replica come un simbolo, un‘astrazione, un ciclo. (Effetto aumentato nel caso di esatta replica.)
Facilmente coglieremo una struttura su cui sintonizzarci con il corpo e con la mente, quindi essere come rapiti da questo sistema di riferimento.
Naturalmente allo scopo di ottenere che la ricorrenza ripetitiva sia percepibile e generi pure un ritmo, gli eventi (gli “oggetti sonori”) devono essere di quantità minima.
| Il moto perpetuo ripetitivo dà un senso di spazio-tempo che non si sviluppa e si estende, ma che è ricurvo e limitato; e quindi la musica non si percepisce come esito di un’attività performante, di un “narrare”, come accade nella stragrande maggioranza delle musiche, ma come di una quasi totale passiva immobilità, di piccolissimi gesti muti: ascoltando queste musiche minimali sembra di stare dentro una stanza con pochi oggetti e con il tempo quasi fermo (il triangolo temporale passato-presente-futuro), piuttosto di viaggiare per una strada piena di realtà pure in movimento... Spesso nei casi di vera e propria musica ripetitiva (cioè definita esclusivamente da cellule soniche che si ripetono), sono comunque introdotte nello scorrere di questi cicli sonori nel tempo delle micro variazioni che “dinamizzano” questi brani: l’esacerbata stasi sensibilizza il fruitore che è così indotto a concedere importanza a qualsiasi minima variazione che succede. | Ascoltando queste musiche minimali sembra di stare dentro una stanza con pochi oggetti e con il tempo quasi fermo |
Tutto ciò crea per noi un‘ipnotica ma costruttiva astrazione-concentrazione del suono fisico e del dato dell‘evento impulsivo formale: questa musica dopo un cospicuo periodo di tempo riusciamo di percepirla finalmente nella sua interezza (e quindi concretarla come realtà spaziale) che è allo stesso tempo così primordiale e futuristica.
Il paradosso è che tutti quegli autori musicali (tra gli altri Philip Glass, Steve Reich, Michael Nyman, John Cage, Terry Riley, Brian Eno) che si sono cimentati in questi processi creativi minimali ripetitivi frutto anche di concetti estetici ben consapevoli, non hanno concepito le loro composizioni dentro precisi schemi formali sia sintattici sia di perimetri temporali, e che quindi le loro musiche potenzialmente potevano essere molto aperte, illimitate, ma come abbiamo già visto hanno conseguito esiti di segno contrario.
Soprattutto nel dintorni del Rock e del Funk, la ripetizione sequenziale più sfruttata in musica si è concretata con l’impiego invalso del Riff (breve e ripetuta frase melodica di solito non più lunga di una o due battute emessa nella tessitura di bassa frequenza).
Ci sono anche i cosiddetti tormentoni musicali, che sono simili ai Riff ma sono emessi su medio-alte frequenze.
Queste cellule melodiche non hanno necessariamente connaturate peculiari valenze ritmiche, ma per il fatto che si ripetono acquisiscono naturalmente importanza anche in questo senso: se emesse in bassa frequenza come nel Riff, la qualità ritmica (pure “armonica”) è di molto aumentata un po’ a scapito di quella melodica (nei tormentoni avviene il contrario).
I tormentoni, che rispetto al Riff hanno pertanto una più spiccata qualità melodica a scapito di quella ritmica (e “armonica”), comunemente si sovrappongono a una breve e reiterata base sequenziale composta di accordi e ritmi; a differenza appunto del Riff che è spesso la struttura di fondamento del brano sopra alla quale si susseguono altre parti.
Dunque il Riff possiede una formidabile qualità ritmica che l‘autosostiene, ed è quindi spesso l‘elemento portante di un intero brano, dove però, differentemente dalla musica minimale, altre parti musicali sono sovrapposte e si susseguono: queste parti essendo un po’ più “discorsive”, lunghe e flessibili del Riff stesso, determinano in queste musiche “movimento” e uno spazio sonoro più ampio di quelle “sospese” e circoscritte caratteristiche invece dei brani minimali.
Questa peculiarità biunivoca (melodica e ritmica) fa del Riff un‘arma musicale molto potente ed efficiente: con poco si ottiene molto.
Questa tecnica di ripetizione parossistica del Riff è una sintesi musicale che genera vigore ed energia appena ci “sintonizziamo” sull’intero evento sequenziale reiterato (che addirittura preso a sé stante ossia non ripetuto potrebbe avere un valore limitato sia melodico sia ritmico).
Ogni volta che il Riff è riprodotto, esso acquisisce un valore diverso: in prima istanza l‘attenzione dell‘ascoltatore è catturata proprio dall‘immediata reiterazione della cellula melodica-ritmica, in un secondo tempo è confortato dalla prevedibilità dell‘evento sonoro, quindi facilitato nel seguire il brano, infine si abbandona al suo incedere inesorabile.
Negli ultimi 50 anni siamo stati invasi dai Riff e dai tormentoni...
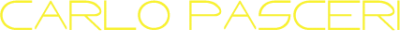

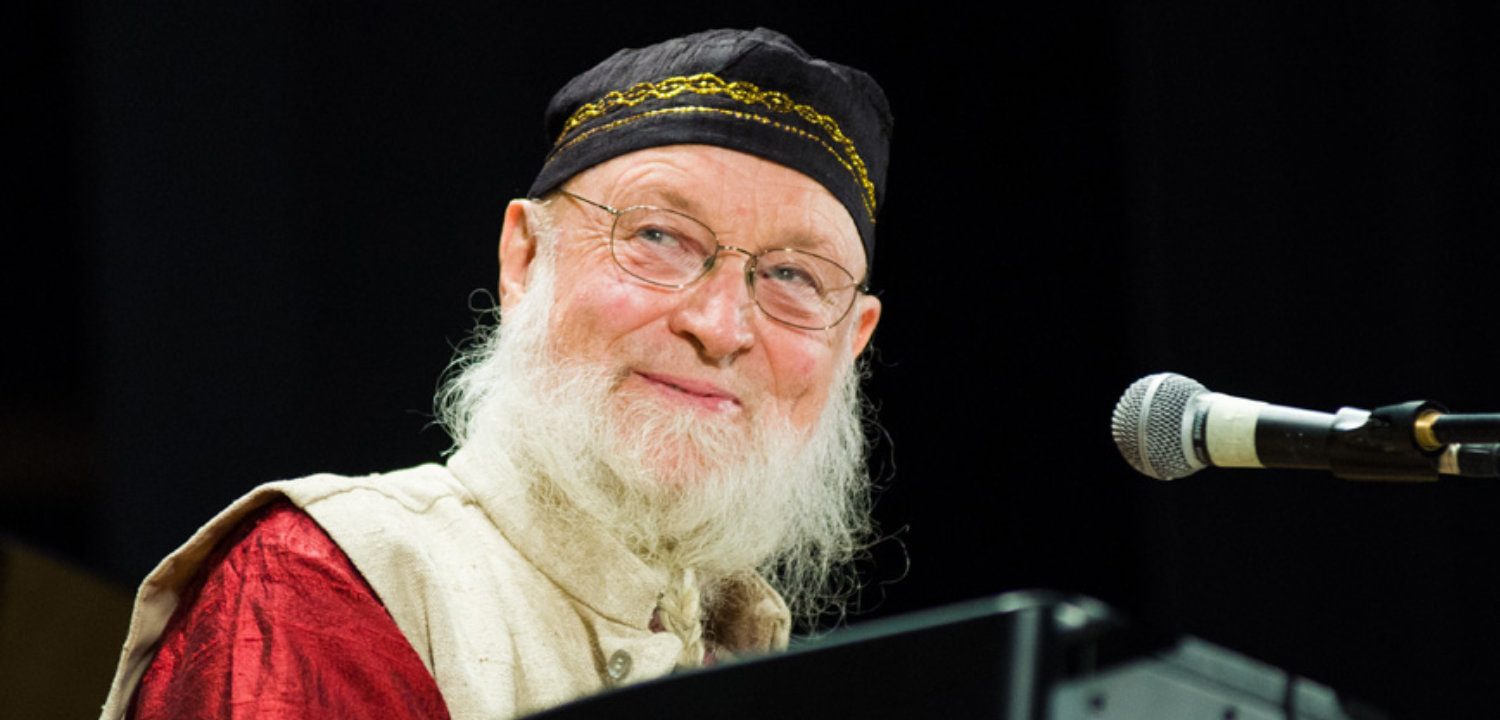
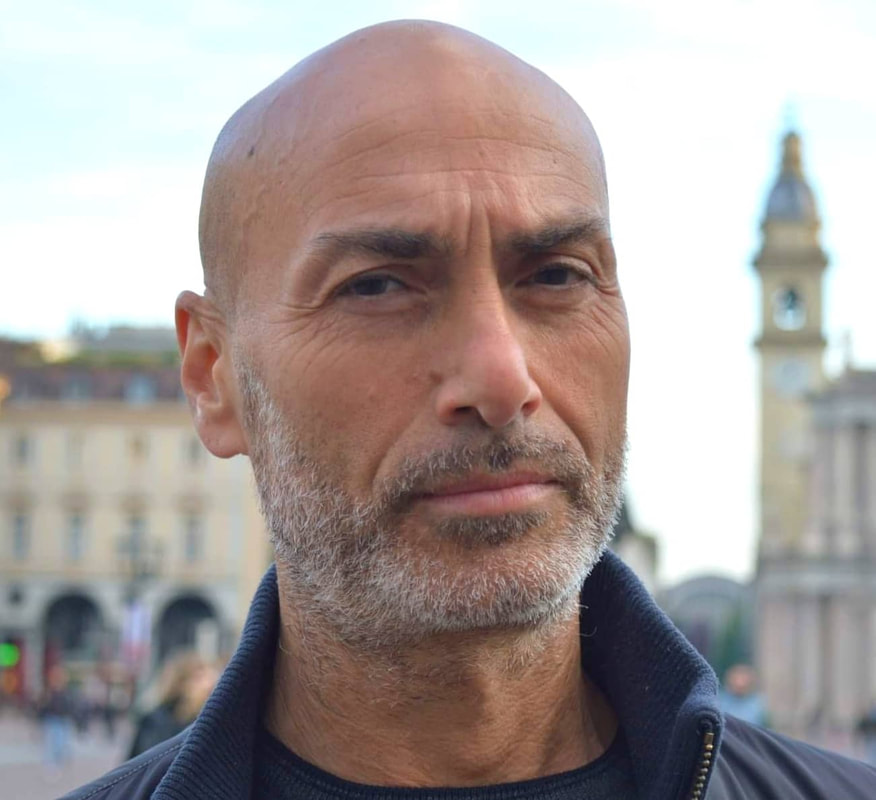
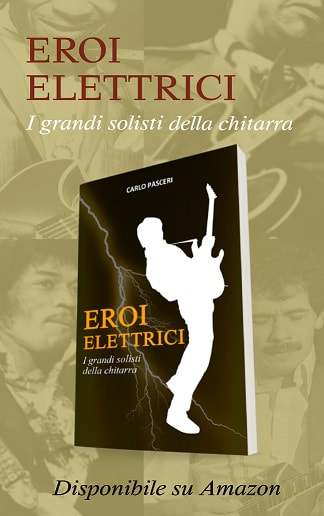

 Feed RSS
Feed RSS
