Gli intervalli tra le note, ossia gli spazi frequenziali, qualificano le varie specie di accordi normati convenzionalmente (maggiori, minori, sus, 7, 9 ecc.) e quindi ne determinano le sonorità: sono percepite con caratteristiche standardizzate di più o meno dissonanza/consonanza, densità/rarefazione, quindi di “colori” più o meno chiari/scuri, finanche più o meno allegri/tristi…
Perciò le peculiarità armoniche sono date dalla mescolanza simultanea tra le note dei singoli accordi e quindi da quanti e quali intervalli li formano. (In seconda istanza, nel quadro complessivo di un brano, dal loro concatenamento ossia la serie di accordi che si svolge nel tempo.)
Se è già noto che le distanze tra le note nel nostro sistema musicale sono predeterminate a livello matematico (Temperamento Equabile), e che già la scuola pitagorica oltre mezzo millennio prima dell’avvento di Gesù Cristo stabilì il concetto di armonia mediante rapporti aritmetici semplici tra le note (2:1, 3:2 e 4:3), è molto importante considerare il numero di note costitutive un accordo giacché esso ne determina l’oggettiva complessità armonica (in termini di combinazioni soniche), pertanto non è importante quali ma quanti siano gli intervalli componenti un accordo.
E un po’ tutti intuitivamente, compresi i professionisti del settore, si è portati a pensare che un accordo di tre note sia solo un po’ più complesso di quello di due e quindi un po’ meno di quello di quattro: una triade ha una nota in più della diade e quindi sarebbe di un terzo più ricco come accordo, la quadriade il doppio di una diade e solo un quarto della triade e via discorrendo.
Non è così.
Le quantità di note, che definiscono la complessità degli accordi, incrementano in modo lineare; non così i numeri degli intervalli armonici: questi corrispondono alla proprietà matematica dei numeri triangolari, simile alla successione di Fibonacci ed essa a sua volta ha una connessione al rapporto aureo. (Analoga questione anche per le stringhe melodiche.)
Una diade (accordo di due note) ha un solo intervallo ed è la più elementare tra le armonie, una triade è costituita da 3 intervalli (chiamiamole sub-armonie), un accordo di quattro note da 6 e quello di cinque da 10. (Per completezza giungendo a quelli canonici fino a sette note: un accordo di sei 15 sub-armonie e quello di sette ben 21.)
Pertanto una triade ha il triplo di intervalli di una diade e una quadriade il sestuplo, una quadriade è il doppio più ricca di una triade; e un accordo di cinque note è formato di oltre il triplo di intervalli di una triade: ecco perché una triade è molto più incisiva di una quadriade insieme con tutte le sensazioni esposte all’inizio compresa quella che accordi di cinque o sei note come giocassero un altro campionato *.
Esempio: la triade di DO maggiore è composta da Do – Mi – Sol, pertanto l’armonia complessiva è data dalla sovrapposizione sonica tra: Do-Mi/ Do-Sol/ Mi-Sol.
Se ci fosse una quarta nota per esempio un Sib (accordo DO7) l’armonia è il globale sommarsi tra 6 coppie di note e non più di 3: Do-Mi/ Do-Sol/ Do-Sib/ Mi-Sol/ Mi-Sib/ Sol-Sib.
Dunque la cognizione che i numeri di sub-armonie costituenti gli accordi ne stabiliscono il grado di complessità** e che non variano in maniera lineare ma in modo altamente matematico, lambendo la sezione aurea (la proporzione armonica per eccellenza), dovrebbe sollecitare una maggiore attenzione nell’optare gli accordi innanzitutto come quantità di note, acquisendo così più consapevolezza e sensibilità nel governare strategicamente le armonie in forme meno legate a schematismi empirici pronti all’uso tattico, che non possono che essere tanto immediatamente funzionali quanto limitanti.
*Ecco perché oltre un certo numero di note, diciamo da cinque in poi, operiamo una sintesi degli agglomerati accordali, tendendo sempre più a polarizzare la nostra attenzione agli estremi frequenziali: il numero di intervalli è così alto che non riusciamo a sentirli analiticamente. Più gli accordi sono composti di note più la nostra capacità selettiva è virata verso la nota più bassa e quella più alta, sentendo quelle nel mezzo come un amalgama con connotati di densità e “colori” diversi a seconda della tipologia degli intervalli presenti.
**Ciò non corrisponde necessariamente alla qualità in senso assoluto o artistico.
Questi argomenti sono trattati nei miei libri Viaggio all'interno della Musica e Quaderni Musicologici.
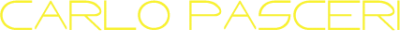

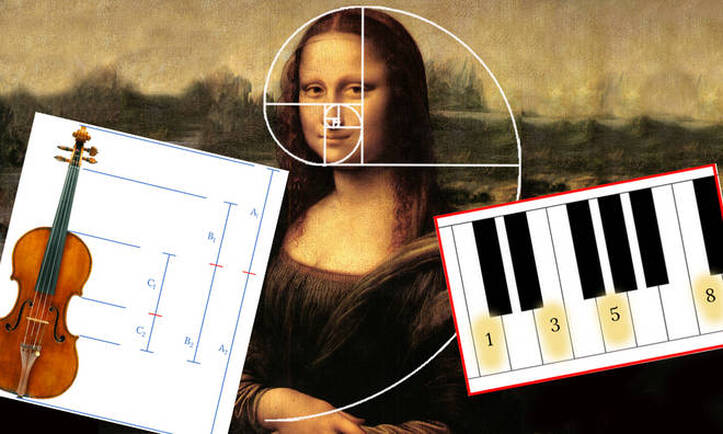
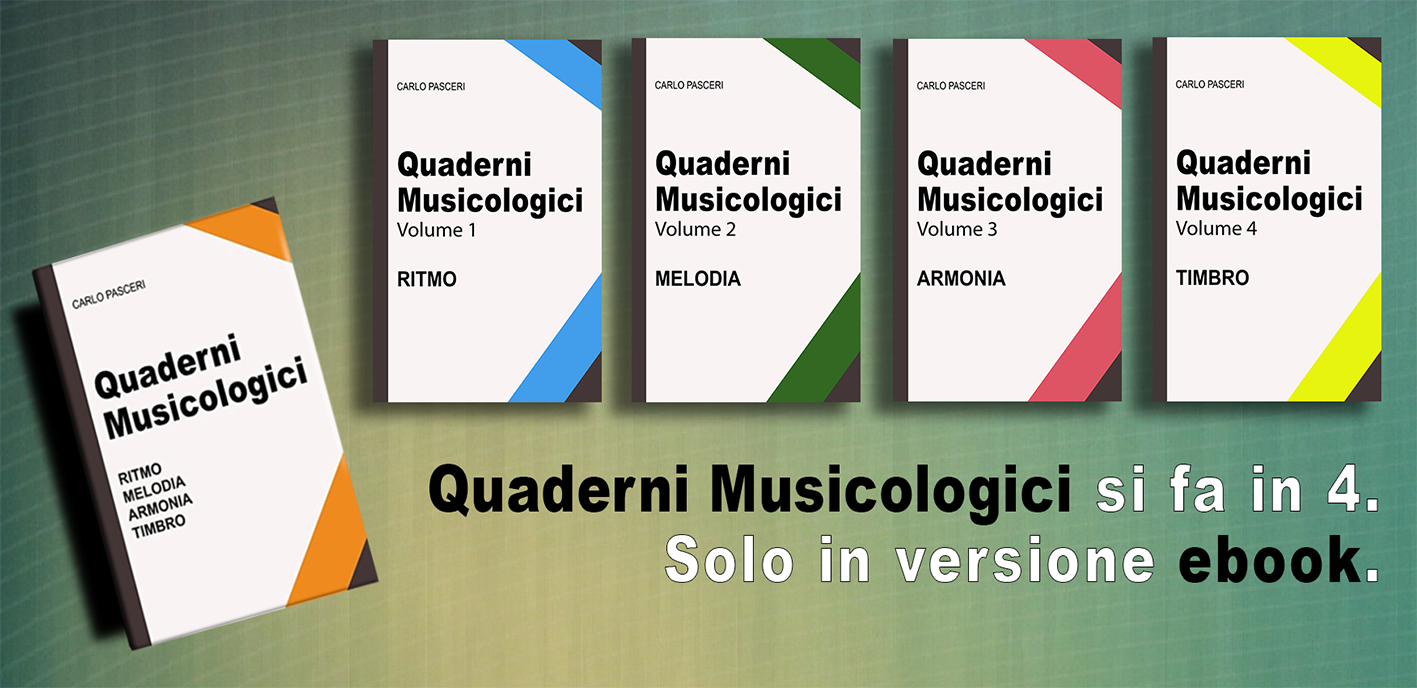
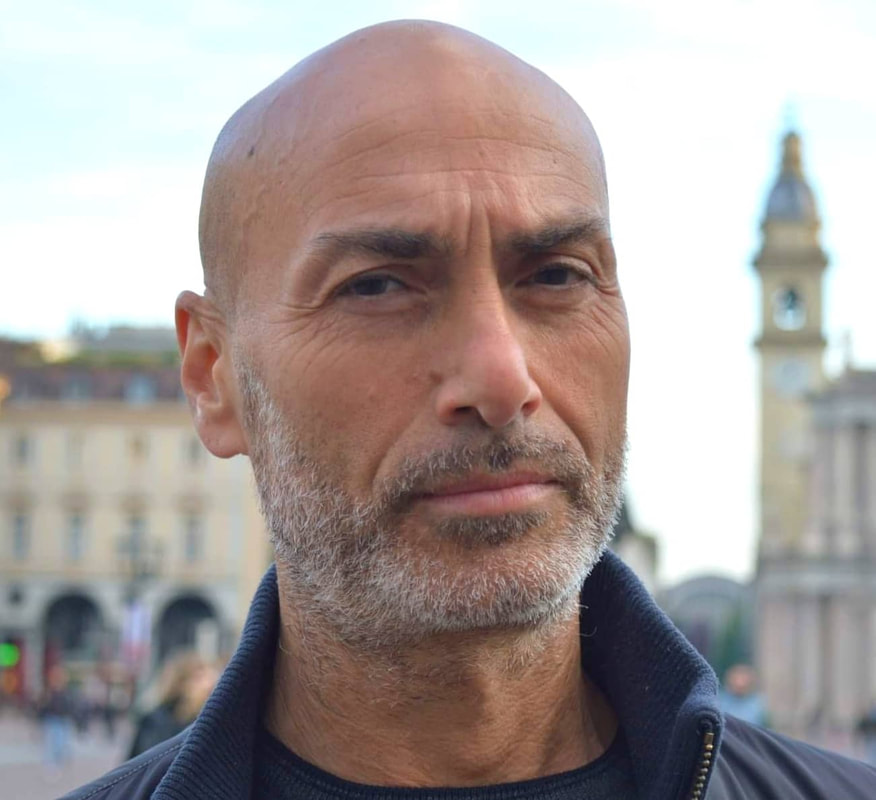
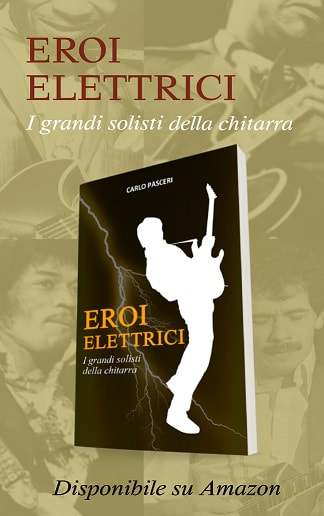

 Feed RSS
Feed RSS
